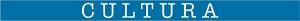Vi è una parte poco conosciuta della vita di Salvatore Satta (Nùoro, 1902 Roma,1975), che ripercorre gli aspetti più intimi e familiari. È una vita “quasi parallela”, che scorre assieme a quella “ufficiale”, di giurista, accademico ed uomo pubblico. Una vita, che, da sardo emigrato, non poteva affatto discostarsi dalle sue origini. Sia che si trovasse a Camerino, a Padova, a Genova, a Trieste, nel drammatico quinquennio 1943-47 dove fu eletto rettore (con nomina ratificata in “prorettore” dal governo militare alleato) o a Roma. E la moglie Laura Boschian, di questo se ne era subito resa conto. E conosceva. Lei che il nostro aveva conosciuto alla fine degli anni Trenta, all’Univer sità di Padova, quando la donna era assistente volontaria all’insegnamento di Letteratura Russa e lui stava per lasciare la cattedra per trasferirsi a Genova. È in quel momento che, quello che sarebbe potuto essere un incontro mancato, diventerà, invece, un incontro fatale. Per Satta Laura sarà la sua dolce e necessaria consuetudine, “porto sicuro” delle sue inquietudini esistenziali e del suo rapporto con la terra natìa. Laura è stata, infatti, la prima ad essere messa al corrente da Salvatore di quell’ “immane” impresa letteraria che ha messo su a partire dai primi anni Settanta. È Il giorno del giudizio.
E la moglie vi era stata coinvolta sia emotivamente, sia professionalmente. E, soprattutto, il coinvolgimento emotivo della consorte, sebbene staccato, si nota nella condivisione di un dramma che, con il passare del tempo, assumeva in Salvatore toni sempre più totalizzanti, in un momento particolarmente delicato della sua esistenza. Era, ormai, malfermo in salute, estraniato dalla vita reale e sempre più introiettato in quella passata “degli inutili morti di Nùoro”. La moglie è stata vicino a Salvatore in questa sua ricerca sulle radici psicologiche. Un lento cammino di redazione sugli stessi fatti della vita che lo hanno ispirato. Un cammino sull’a nimo di chi ha liberato Satta dall’abisso oscuro ed aggrovigliato della propria coscienza. Ed il dato rilevante è quello di percepire come, nell’opera letteraria di Satta, vi sottostia “una tragedia rimossa sconosciuta”. E scriviamo di un senso diffuso di colpa verso la madre, un sentimento ambivalente nei confronti del padre, una rivalità mai sopita e mai ricomposta con i fratelli. Lo stesso “grovi glio intimo” che sembra nutrire per la sua città, Nùoro, definita “nido di corvi”, da un lato, ma anche unico punto fermo su cui, nonostante tutto, dirigere la barra della propria navicella. Una “storia di famiglia”, quindi. A partire dalla sorte e dal tono riserdi vati al fratello Filippo, il “Ludo vico” del Giorno. Pagine irridenti per un uomo ricordato da tutti all’opposto a Nùoro. Un fratello cui lui aveva amorosamente dedicato la sua prima opera scientifica, L’esecuzione forzata del 1937. Questa irriverenza verso il fratello è una ferita più lontana, più intima e più profonda. “È un maleficio che fu dalla nostra culla e che ha mutato in bozzacchioni le susine vere”. È quella sorta di “male originario” che Satta percepisce verso la sua famiglia, di tradizione e, per tanti versi, “infi nitamente dotata”. Ma, che, per altro, non ha saputo vivere. E neanche morire. Un malessere, quindi, quello sattiano, che va oltre il dato singolo, da intendersi come un’ombra diffusa, la paolina “spina nella carne” che farebbe più pensare ad una condizione persistente degli stessi rapporti all’interno della famiglia Satta. Quello che possiamo dire, quindi, è che in tutti gli scritti del grande giurista nuorese, dalla Veranda, ai Soliloqui e colloqui, alle Lettere ad Albanese, al Giorno, compare costante un rimpianto senso di colpa nei confronti della madre, donna Antonietta. Un “martirio”, il suo, di donna intelligente e buona, lento e crudele, maturato, soprattutto, non solo per opera del marito don Salvatore, ma soprattutto per l’atteggiamento omissivo di tutti i figli. E neanche Satta se ne esludeva in prima persona, come, d’altronde, scrive, con espressioni autoaccusatorie, nel XX capitolo. Racconta di sé che rientrava dalle vacanze, piangeva per lo stato di quella povera donna “inchiodata dall’artrite nel seggiolone”, ma poi ripartiva e non dava più notizie. E non era indotto a fermarsi né dalle piaghe, né dalle preghiere della madre. La morte di lei è arrivata da cesura. È rimasta nella mente di Salvatore “la sua vita di dolore che nessun Dio può fare che non sia stata”. Assieme al rimorso della propria personale assenza per essere andato via, anche lui, “a cercare pane migliore di quello di grano”. Ma è, appunto, da quella ricerca che è nato, sebbene postumo, un capolavoro esistenziale come I l giorno del giudizio , scritto e pensato in Continente, per la Sardegna e per Nùoro, la Spoon River del mondo.