L’uomo che volle essere Verdi
di MARCO MAUGERI
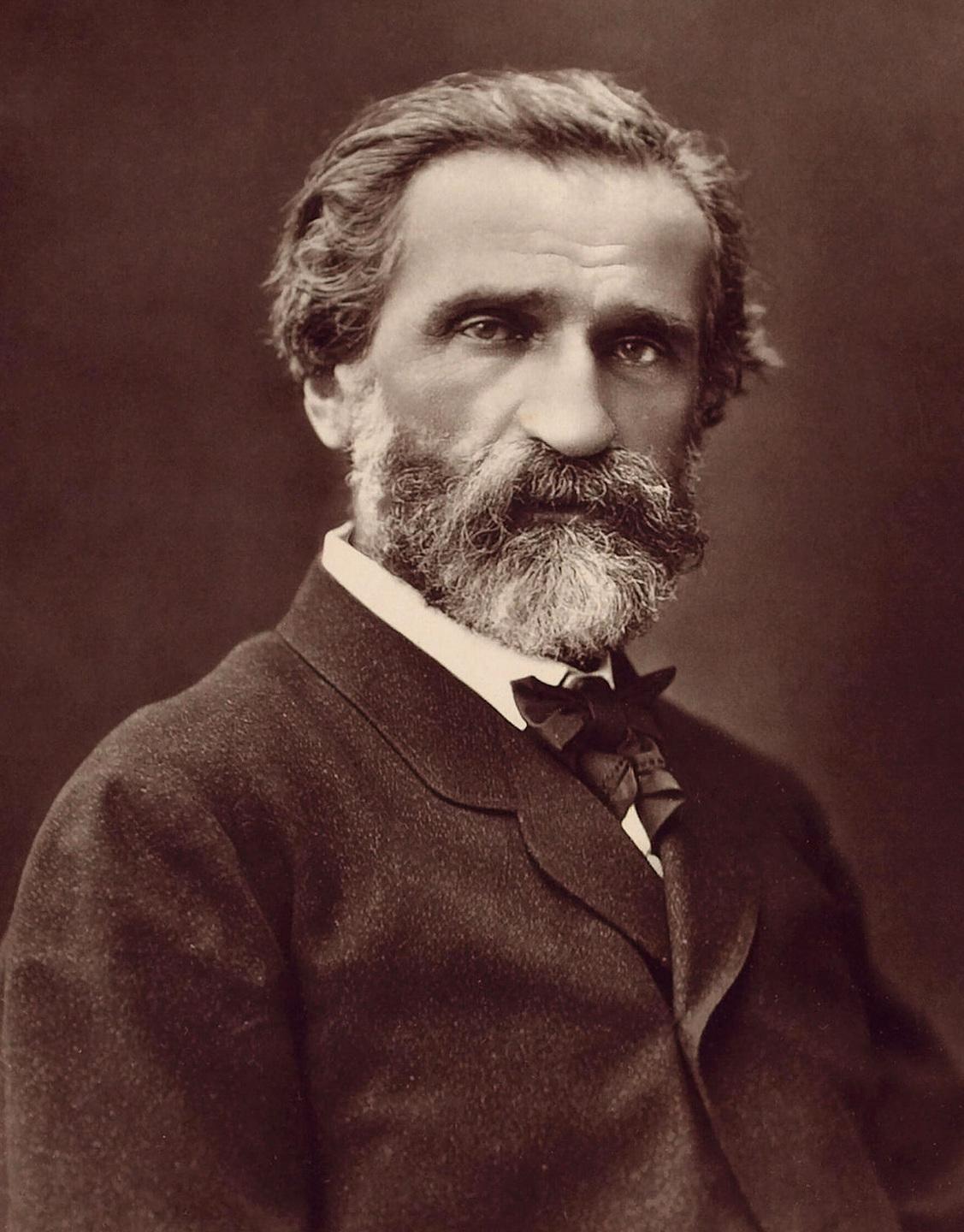
E-dicola
Video
Libri
La capacità di unire

Tre lasciti, due forti sensibilità, tre interrogativi aperti. Sono l'eredità che Papa Prevost ha ricevuto da Papa Bergoglio
Magazine
Via Po Cultura

Riattivare la passione per la democrazia. Intervista al filosofo e saggista Corrado Ocone
Libri
Un ritratto fedele

La favolosa Elsa di Renzo Paris è un’al tra ricostruzione del tempo andato, di quell’e poca straordinaria dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta, contrassegnata dalla scuola romana










