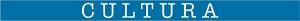Ci sono arrivato in un torrido pomeriggio d'inizio agosto, lasciatomi alle spalle il paese di Salgareda (TV), in una località chiamata Gonfo, a ridosso del letto del fiume Piave, Sacro alla Patria, quasi in secca. Desideravo da tempo poter visitare la “casa delle fate” di Goffredo Parise (1929-1986), magistralmente raccontata da Silvio Perrella nel suo “Fino a Salgareda”, Neri Pozza Editore.
E anche da Claudio Rorato nel suo prezioso “Goffredo Parise a Salgareda”, Ronzani Editore, 2019, una “specie di casa delle fate, minuscola e vecchia” sulle rive del Piave.
Di quel “piccolo Eden profumato di sambuco, dove il vento leggero e già fresco volteggiava insieme ai molti uccelli: merli, passeri e improvvisamente un cuculo e un picchio. L'aria era color viola...”, lo scrittore si innamora durante una cavalcata d'inizio estate sull'argine del Piave: si ferma a guardare una casa golenale disabitata e col pavimento in terra battuta. “Se viene via per niente la compro” dice al compagno di cavalcate Guido Carretta.
È il 1970, il romantico rudere viene via per poco o niente e l'affare si compie. Poco prima del Natale dello stesso anno “el dotòr”, come lo chiamavano da queste parti anticipando rudemente la laurea honoris causa dell'86, inizia a stare nella “casa delle fate” dopo averla resa abitabile.
Vi trascorrerà quasi tredici anni, tra i suoi più felici e fecondi in cui vedranno la luce i “Sillabari”.
Giovanissimo, Claudio Rorato fece amicizia con lo scrittore, e in queste pagine se ne avverte l’eco. Vi è ricostruita con emozione la storia del piccolo edificio, così resuscitando modi di vita e di lavoro ormai lontani. Si apre, inoltre, uno squarcio mirabilmente preciso sul mondo animale e vegetale che vive, ora segreto, ora manifesto, intorno all’incantevole ritiro. Da allora, il paesaggio ha subito alcune ferite per mano dell’uomo, oltre alle gravi devastazioni prodotte dalle alluvioni del fiume – ultima, quella dell’ottobre 2018. Eppure, la Casetta resiste. Dopo il trasferimento di Parise a Ponte di Piave, ha cambiato due volte proprietari: entrambi rispettosi del “sonoro interno” che tuttora si avverte in quegli spazi, ne hanno custodito la peculiare natura. Oggi, la Casetta è aperta ai visitatori che la frequentano in gran numero dando corpo, ciascuno, a un’immagine dello scrittore sempre viva e sempre nuova, come la recente Mostra di Giuseppe Lollo (1940-2020) “Ho scelto la pittura”, fortemente voluta dalle amministrazioni comunali di Ponte di Piave e Salgareda, che ha dipinto per un'intera esistenza senza pensare mai a scadenze espositive, ma con un unico scopo: migliorare le opere precedenti.
Poche le modifiche, come l'apertura di una finestrella sul letto nel lato Nord per vedere le alpi venete imbiancarsi d'inverno e un'upupa nidificare a primavera. Qualche soldo dato a un contadino perché non coltivi niente e lasci libera la vista verso il fiume. Al colpo di fulmine immobiliare segue quello erotico. Lo scrittore incarica un fabbro dal cupo nome, “Bepi il nero”, di recuperare dei chiavistelli ruggini per la “casa delle fate” e si innamora della ruvida figlia: Omaira Rorato, “la selvàdega”, frequentando la famiglia adottiva come altre del luogo alla sua maniera e cioè presentandosi a cena senza invito, solitario e scorbutico, o in vena di parlare a seconda della sera. Quando le dice “Io sono lo scrittore Goffredo Parise” lei risponde: “Chis senefrega!”.
Nel gennaio del '71 Parise pubblica sul Corriere della Sera il primo racconto dei “Sillabari”: “Amore” dopo avere visto il figlio dei vicini scrivere su un sillabario. Vincerà lo Strega con quei racconti e tutte queste linee del destino si incrociano come combinazioni astrali irripetibili ed effimere tra le mura della casetta rosa.
Alla relazione tra “el dotòr” e la “selvàdega” Tommaso Tommaseo Ponzetta ha dedicato un libro intitolato “Omaira. Un amore di Groffredo Parise”, Piazza Editore.
Nata in Venezuela, mora, formosa e dal bel profilo, la giovane figlia di “Bepi il nero” è primitiva quanto basta per scuotere lo scrittore quarantenne, annoiato dai salotti romani, in cerca di una patria dove tornare dai viaggi e ormai convinto di avere poco da vivere tanto da spendere milioni in un fucile da caccia inglese, un Purdey.
Rimasta magicamente intatta per vent'anni dalla morte dello scrittore, la “casa delle fate” viene comprata nel 2006 da due appassionati lettori di Parise, Enzo Lorenzon e Moreno Vidotto.
Il Lorenzon se n'è andato e ha lasciato la sua quota al Vidotto, ora unico proprietario e appassionato custode anche di memorie parisiane.
Con la storica compagna, la pittrice Giosetta Fioroni, il cuore viene diviso per competenze territoriali, pur tra gelosie e follie. A Salgareda Parise vive una seconda vita e lo stesso fa Giosetta a Roma. Si delinea una complessa e morbosa geometria amorosa a quattro che prenderà forma narrativa nell'opera postuma “L'odore del sangue”, in quell'area golenale in cui la vita diventa romanzo esondando nella letteratura. Il libro esce nel 1997, fortemente voluto da Cesare Garboli, benché il manoscritto fosse incompiuto, e diventa un film per la regia di Mario Martone.
Omaira non sa niente dell'operazione e rompe i rapporti con Giosetta, nati dopo la morte dello scrittore in nome del comune amore perduto. La morte non è che l'esito di un percorso patologico iniziato da anni. Un giorno del '76 Parise mangia una pesca gelata-intorno alla casetta ci sono peschi, amareni, gelsi.. - e va a passeggiare come tante altre mattine sull'argine del Piave.
Si sente male e pensa a un problema digestivo ma ha avuto un infarto. I medici gli dicono di smettere di fumare. Non li ascolta, si riprende tanto che nel '77 piomba a Salgareda in preda alla gelosia quando Omaira viene corteggiata da un giovane ufficiale siciliano. Le dice di diffidare dei siciliani. La lotta con il cuore e altri organi malati è un susseguirsi di crisi e tregue fino alla sconfitta finale. Il pericolo si dilegua e ricompare. Arriva nel '79 il secondo infarto.
Parise guardava alla malattia come espressione di una patologia più grande che comprende tutte le altre ed è incurabile, vale a dire la vecchiaia seguita dalla morte.
Certo, scrive, la vecchiaia si può alleviare e la morte ritardare compiendo una rinuncia dopo l'altra, ma si inizia così comunque a morire. La malattia va dunque “maltrattata”. Riguardarsi, smettere di fumare per esempio, significa firmare la resa anzitempo. La visione dello scrittore sulla malattia e la morte è oggetto di un altro libro di Tommaso Tommaseo Ponzetta, “A cena da Goffredo Parise e altri racconti”, Piazza Editore.
Omaira vive ancora vicino alla casa delle fate, a Ponte di Piave, due minuti da Salgareda. Qui Parise si trasferisce quando deve ricorrere alla dialisi, in una villa meno tolstoiana della casa di Salgareda ma più confortevole. La casa è piena di quadri-in particolare Schifano-e oggetti dello scrittore: dai romanzi di Malaparte e Morselli alla tessera dell'Alitalia. Nel giardino sono interrate le ceneri sotto a una scultura di Brancusi. È la copia di una copia perché la copia “originale” è stata rubata appena dopo la morte di Parise da qualcuno che la credeva autentica.
La morte segna nel bene e nel male il destino della coppia golenale. Nei primi anni '70 Omaira è fidanzata e si sposa nel 1975 ma resta vedova sei mesi dopo e da quel punto diventa devota all'ingombrante figura dello scrittore pur restando spigolosa come sempre. In una foto del '76 a Jesolo lui la abbraccia da dietro come per tenerla legata a sé. Parise era un amante possessivo e al tempo stesso inquieto e in fuga perenne.
Omaira lo andrà a trovare al Policlinico Gemelli di Roma quando lo colpisce il secondo infarto e ascolterà divertita la storia del compagno di stanza che si sveglia senza capire dove si trova, si alza dal letto e cerca di fare la cacca nel cestino dei rifiuti cadendo infine con la flebo e tutto il resto. E lo assiste nell'ultima fase della malattia, sino alla morte che sopraggiungerà il 31 agosto del 1986.
Nel lasciare la “casa delle fate” di Salgareda mi è tornata in mente una lettera, bellissima e struggente, indirizzata da Goffredo Parise a Dudù La Capria, un invito fraterno a raggiungerlo e ad unirsi a lui in quel “veneto barbaro di muschi e nebbie”: Salgreda, 10 dicembre 1973 “Mio caro Duddù, La mia vita comincia prima dell’alba, è molto felice all’aurora e rimane felice per tutto il giorno e parte della notte, fino a quando vengo svegliato da cattivi pensieri; ma poi è l’alba e di nuovo la vita felice. So di poterti dire queste cose perché mi hai sempre dato ciò che cercavo dagli uomini e dall’arte. Tu mi hai dato i sentimenti e ora voglio bene e ricordo solo quelle persone che hanno il cuore, altre che non hanno cuore (e tu sai benissimo a chi mi riferisco delle due categorie) le ho dimenticate e le ricordo con irritazione e pietà insieme. Vado molto a caccia, in valle e altrove, sempre solo. Ho nostalgia di quelle persone col cuore soprattutto di Giosetta.
Vado anche a sciare (stupenda neve vergine a Cortina, solo, solissimo a 3200 metri e giù nella neve vergine fino a 2000 metri) vedo scoiattoli già bianchi, anche lepri bianche, sono felice come dovessi morire tra poco. Lavoro pochissimo e intensamente, facilissimamente come dovessi suonare il pianoforte, so quello che scrivo ma la tua lettera mi ha fatto piangere perché ho visto il cuore che palpitava e avrei voluto, vorrei ora portarti con me in botte (parto ora, sette di sera, vado in laguna, domani sarà bel tempo ma freddo, forse ghiacciato) dove mi accadono con le anitre cose che mi accadono con gli uomini che amo ( non con quelle che uccido, le belle, le bellissime, le provocatrici – germani reali, alzavole, fischioni – ma con quelle che non uccido, i semplici e cari e comici e simpaticissimi mestoloni, detti foffani – che nome stupido e stupendo – le povere folaghe, i buonissimi e splendidi aironi). Sono incatenato a questo posto, amo tutto, la legna che butto sul fuoco, la brina nella boscaglia del Piave, e quel mistero, quella magia di cui mi sento così investito, onorato e riconosciuto (da te) non è mia ma mi viene trapassata da tutto questo.“ Che bella lettera mi hai scritto, che onore mi fai. Quelli che mi vogliono bene pensino a me come a una persona morta che però è viva e felicissima, tra i giorni che passano come il vento, che ha cambiato vita e non sa né come né perché. Ora parto Duddù, vieni con me, copriti bene, Aurora porta vento gelato dalle montagne serene e rosee coperte di neve, che increspa la laguna e muta maree. A quell’ora passano alti, fuori tiro, i primi germani a stormo perfetto, aerei dalle ali fischianti. Vieni con me Duddù, vieni che ti porto via.
Goffredo P.S. Scrivi del tuo doloroso capire tutte le cose' .