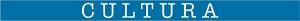Il pensiero di María Zambrano è così carico di tensioni e diramazioni che bene fa l’autore di questa ricostruzione a interpretarlo nel segno di uno dei suoi concetti-simbolo fondamentali: quello di claritas il cui significato proviene direttamente dall’opera “Chiari del bosco” scritta dalla filosofa spagnola a La Piéce vicino a Ginevra dove visse tra il 1964 e il 1978. E’ questa una delle fasi del lungo esilio al quale la filosofa spagnola fu costretta a partire dal 1939, con l’inizio della dittatura di Franco. Intanto ci viene ricordato che si parla di “chiari” al plurale per alludere al fatto che la claritas non è una manifestazione necessaria e preordinata dell’essere ma una molteplicità di modi, una disseminazione di segni, di appelli e di accenni che non possono essere riuniti sotto un unico significato.
Se così fosse, pare di capire, non ci sarebbe nessun segno, nessuna manifestazione e, soprattutto, nessuna luce, perché ci si troverebbe di fronte a una limitazione-costrizione del senso. Ovviamente il chiarore non è l’essere ma la condizione della sua manifestazione, lo spazio franco e libero dai significati prefabbricati in cui si danno le sue numerose ma imprevedibili possibilità. Possibilità che in Zambrano non sono tanto legate al discorso della ragione logica, che anzi arretra platonicamente nella ricerca del mistero, quanto al discorso della ragione poetica, un sentire originario, una guida quasi animale, che precede le costruzioni intellettuali della filosofia e della teologia segnate, in modo particolare, dal cartesianesimo e dalla soggettività ipertrofica.
Anzi, da quelle discipline, che Heidegger definisce ontiche, accusandole di aver messo in ombra l’essere dietro l’ente, Zambrano prova a dissociarsi con esiti talvolta mistici ma mai ostili al logos. Semmai il suo è un tentativo di arricchire il logos, di incrementarlo con le ragioni del cuore, del sentimento, dell’intuizione, dell’immaginazione.
In “Dell’Aurora”, altra opera potentemente metaforica del periodo di La Pièce, la filosofa scrive: “La conoscenza che qui invochiamo, che sospiriamo, questa conoscenza postula e richiede che la ragione si faccia poetica senza rinunciare ad essere ragione, che accolga il sentire originario senza coazione, liberamente, naturalmente quasi, come una physis restituita alla sua condizione originaria”.
Si tratta di evitare “l’ansia di captare, la tirannia del concetto”, la patologica super-attività del soggetto che va restituito, invece, a una forma salutare di passività e di accoglienza. Nel ripercorrere questo itinerario che oscilla, come sua propria ragion d’essere, tra logos e pathos, incontriamo richiami a pensatori e orientamenti diversi a conferma di una riflessione che intende programmaticamente aprirsi, a vari livelli, all’altro.
Altro è il sacro ma altro sono anche tutte le voci che attraversano la trama dell’esistenza. Anche le voci filosofiche qui chiamate a raccolta: Ortega y Gassett, ovviamente, il maestro, e poi i contemporanei come Max Scheler, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel Lèvinas, William James, i classici come Platone, Aristotele, Agostino, Pascal, Spinoza, Hume, Kant, i mistici tra cui San Giovanni della Croce. Insomma, uno studio molto denso e documentato, ulteriormente arricchito nell’ultimo capitolo dal confronto tra il pensiero della filosofa spagnola e la teoria delle emozioni costruite della psicologa Lisa Feldman Barrett, promotrice e studiosa di quella che oggi viene chiamata “scienza affettiva” di cui, almeno nel nostro paese, si sa ancora molto poco.