Tra il 1989 e il 1992 cambia l’Europa: crolla il muro di Berlino e si dissolve l'Unione Sovietica, mettendo fine alla Guerra Fredda. Di conseguenza cambia l’Italia: entra in crisi il sistema politico e finisce la cosiddetta Prima Repubblica. In quel periodo Giulio Andreotti era presidente del Consiglio, Francesco Cossiga presidente della Repubblica. Tra questi due statisti c’è un dialogo istituzionale e personale quasi quotidiano. Un rapporto che riemerge nel fitto carteggio pubblicato in più volimi dal prof. Luca Micheletta, ordinario di Storia delle Relazioni internazionali presso il dipartimento di Scienze politiche dell’Università La Sapienza di Roma. Micheletta ha portato alla luce la documentazione che è conservata nell'Archivio Andreotti presso l'Istituto Sturzo e presso l'Archivio della Presidenza della Repubblica. Un lavoro che rappresenta il potenziale avvio di una riflessione non solo su quel momento storico ma sulle origini di quella transizione politica-costituzionale della Repubblica italiana che ancora oggi appare incompiuta. Andreotti e Cossiga erano profondi conoscitori della macchina istituzionale e le domande che all'epoca si posero e le problematiche che cercarono di affrontare sono tutt'ora all'ordine del giorno.
Prof. Micheletta, il carteggio Andreotti-Cossiga ha interesse anche oggi perché tocca temi che legano il passato al presente. Vorrei partire con la questione, drammaticamente attuale, della guerra. Andreotti e Cossiga si confrontano su quale deve essere la posizione dell'Italia a proposito dell'invasione del Kuwait nell'agosto 1990. Cosa emerge dalla lunga corrispondenza?
È un momento molto particolare nella storia della Repubblica, che per la prima volta è chiamata a decidere se partecipare a una guerra, benché una guerra per ristabilire la legalità internazionale violata dall’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq. La corrispondenza segue il dialogo istituzionale tra Quirinale e governo e le loro riflessioni sull’intepretazione da dare all’art. 11 della Costituzione, che si apre, come noto, con l’espressione del ripudio della guerra e che seguita affermando che l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte allo scopo di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. A giudizio di Cossiga e di Andreotti, le sanzioni economiche e le operazioni militari contro l'Iraq andavano tutte gestite all'interno del sistema giuridico dell'ONU, che costituiva una delle poche eccezioni al ripudio della guerra iscritto nell'art. 11. Cossiga, ad esempio, si oppose a un rafforzamento con truppe di terra della missione navale italiana già presente nell’area del Golfo, perché ciò era incompatibile con l'art. 11, e suggerì l'invio di una forza aeronautica di caccia-bombardieri Tornado come appoggio alla missione navale stessa. Il presidente della Repubblica, inoltre, negò l’assistenza logistica richiesta dagli Stati Uniti nell’ambito degli impegni della NATO, perché la clausola di solidarietà atlantica scattava in caso di attacco a uno dei membri e il Patto Atlantico non contemplava operazioni fuori area.
Altro tema del carteggio è la riforma della giustizia, considerata urgente già allora soprattutto per la risposta da dare all'aggressione della criminalità organizzata. Una riforma che chiama in causa anche il Csm. Quali erano le posizioni in campo?
La lotta alla criminalità organizzata è uno degli argomenti più trattati nella corrispondenza. È una preoccupazione per Andreotti ed è un vero e proprio cruccio per Cossiga che costantemente stimola il governo ad attivarsi, riorganizzando le forze dell’ordine e i servizi di intelligence. La riforma della giustizia, a cominciare dalla riforma del processo penale, è un altro tema che Cossiga affronta con molta decisione e con i toni polemici che hanno caratterizzato gli ultimi due anni del suo mandato presidenziale. Con il CSM, che pure è presieduto dal presidente della Repubblica, Cossiga era entrato in conflitto già nel 1985, ma dal 1990, anche in relazione alle accuse di cui fu oggetto a causa della sua difesa della legittimità di Gladio, riaccende la polemica con toni molti aspri, ritenendo che il CSM fosse un organo in mano alle correnti politiche e si arrogasse competenze al di fuori della legge e della Costituzione. Il carteggio con Andreotti mostra tutti i passaggi dello scontro istituzionale tra il Quirinale e il CSM e anche di quello personale che si apre con il suo vicepresidente, Giovanni Galloni, circa i poteri del CSM. E documenta anche la clamorosa iniziativa di Cossiga, del novembre 1991, di impedire la riunione del CSM, che a suo avviso stava operando fuori della legalità costituzionale, con la minaccia di far intervenire i carabinieri. Una pagina a parte di questo capitolo va dedicata al contrasto tra Cossiga Presidente della Repubblica e Andreotti Presidente del Consiglio sul decreto legge del settembre 1989 che ampliava il periodo di custodia cautelare per gli imputati di mafia già condannati in primo grado nel maxiprocesso a Palermo istruito da Falcone e Borsellino. Il carteggio testimonia come i due statisti avvertano la pericolosità sociale del fenomeno mafioso e l’urgenza di combatterlo, ma hanno sensibilità diverse, anche per il ruolo istituzionale che rivestono. Il ministro della Giustizia Vassalli e Andreotti sostengono il decreto per evitare che, a causa del prolungamento dei tempi processuali, possano essere rimessi in libertà imputati al maxiprocesso. Cossiga assume una posizione garantista ed esprime tutti i suoi dubbi: firmerà infine il decreto, denunciando le gravi insufficienze del sistema della giustizia, proprio come l’abnorme durata dei processi, che comportava la violazione dello stato di diritto e, in particolare, dei principi relativi alla presunzione di innocenza e alla libertà personale. Nel 1994, nel pieno di mani pulite e mentre Andreotti era nella bufera giudiziaria, Cossiga gli scriverà che i suoi timori nell’adottare una legislazione potenzialmente antigarantista e giustizialista si erano rivelati tragicamente fondati.
Un terzo tema di grande attualità riguarda la riforma delle istituzioni. Nel giugno 1991 Cossiga dal Quirinale invia un messaggio alle Camere che sostanzialmente viene ignorato. Qual era in sintesi il contenuto di quel Messaggio? E cosa ne pensava Andreotti?
Il messaggio ricostruisce il momento storico in cui è nata la Costituzione del 1948, ricapitola i vari tentativi di riforma delle istituzioni che si erano fino ad allora compiuti e indica modi e vie per giungere, nel più breve tempo possibile, a un processo riformatore. Cossiga avverte che il mondo sta cambiando con la fine della guerra fredda e il messaggio è lo strumento per richiamare le forze politiche in Parlamento sull’urgenza di procedere alle riforme costituzionali, per rinnovare sostanzialmente la Repubblica e metterla in grado di far fronte alle sfide del mondo nuovo. A parte la disputa sulla controfirma del messaggio, che Andreotti preferì fosse apposta dal ministro della Giustizia, Martelli, appare chiaro che Andreotti non vede la stessa urgenza, né condivide lo stesso giudizio negativo sull’esperienza e il funzionamento della cosiddetta prima Repubblica, giudizio che emerge dal messaggio di Cossiga stesso. Per Andreotti, al centro del sistema costituzionale deve rimanere il Parlamento, come nella carta del 1948. Andreotti è un riformatore prudente e sempre sospettoso di ogni radicale mutamento, anche di quelli di natura costituzionale. È un tratto tipico del suo carattere, che si riverbera sulla sua azione politica.
Caratteri diversi, idee a volte non collimanti; ma stesso senso dello Stato e delle relazioni personali. Ci racconta un episodio simbolo in questo senso?
A partire dal 1991 il carteggio registra forti dissensi su molte questioni o anche periodi di freddezza e, talvolta, da parte di Cossiga, scoppi d’ira nei confronti di Andreotti. Ma entrambi furono attentissimi a non trasformare i disaccordi politici e quelli istituzionali in conflitti di natura personale. Le più dure lettere di Cossiga si chiudono sempre con l’auspicio che il contrasto non tocchi il loro rapporto d’amicizia personale e l’assicurazione che per lui sarà così. Non dobbiamo dimenticare che sono due statisti profondamente cattolici e che la loro fede sostanzia il loro impegno politico. Nel 1992, nel pieno di un acrimonioso dissidio sulla legge sull’obiezione di coscienza, scriverà ad Andreotti che l’evitare che il conflitto politico turbi il rapporto personale «dipende non certo da umana prudenza, furbizia o diplomazia, ma dalla capacità che noi avremo di preservare, anche nel contrasto, le ragioni della carità e della umiltà, in cui entrambi crediamo». Ma la corrispondenza contiene anche momenti esilaranti: proprio nel periodo di fine mandato, quando Cossiga non risparmiava picconate a destra e a manca, suscitando roventi polemiche e preoccupando Andreotti per le loro conseguenze politiche e istituzionali, gli inviò in regalo l’ultimo tipo di televisore portatile affinché – gli scrisse – anche in viaggio non si perdesse nessuna delle vivaci esternazioni presidenziali e stesse più tranquillo…
C'è poi la vicenda Gladio. L'esistenza di questa struttura segreta a difesa dello Stato fu resa nota da Andreotti nell'ottobre 1990 con il crollo del Muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda. Il Presidente Cossiga sostenne con forza la legittimità di quella struttura e anche per questo fu richiesta la messa in stato d'accusa, richiesta che non ebbe successo. Cosa emerge in proposito dal carteggio?
Cossiga e Andreotti concordano sulla decisione di sciogliere Gladio, una struttura nata a fine anni Cinquanta con il compito di organizzare la resistenza all’interno del territorio italiano in caso di invasione del patto di Varsavia. Né ci sono diversità nel giudizio sulla sua legittimità, che Andreotti, come aveva fatto pubblicamente Cossiga, affermò in sede parlamentare. Ci furono però all’interno del governo posizioni di singoli esponenti che dubitarono della legittimità e degli scopi di Gladio, come ad esempio il ministro Formica, che generarono un forte scontro con Cossiga e che portarono Andreotti, come dimostra il carteggio, a minacciare le dimissioni nel caso in cui il governo non avesse preso una chiara, unanime e pubblica posizione nel senso della legittimità, confermando il giudizio dato dal capo dello Stato.
Anche se nel carteggio non ci sono riferimenti espliciti non possiamo non citare il caso Moro. Cossiga e Andreotti vissero quella vicenda come dramma personale prima ancora che istituzionale lasciando tracce profonde sulla vita di entrambi. Da curatore di questo carteggio che idea si è fatta della loro gestione di quella vicenda? Al di là della dichiarata impossibilità a trattare in nome dello Stato e della Dc, Andreotti e Cossiga potrebbero avere percorso strade riservate e concrete per la salvezza di Aldo Moro?
Nel carteggio non c’è nulla relativo al 1978, ma si evince bene dai riferimenti che vi fanno, che quello fu un momento traumatico nella vita di entrambi e quello in cui saldarono il loro rapporto personale. L’impressione che ho tratto da ciò che ho letto della vicenda del rapimento Moro, anche nell’Archivio Andreotti, è quella che si trovarono a gestire una situazione che né esponenti politici, né apparati dello Stato erano preparati ad affrontare. La conseguenza fu che si presero decisioni estemporanee e disordinate, al limite dell’improvvisazione. Quanto a Cossiga, vorrei ricordare che egli ha avuto in Aldo Moro, fin dagli inizi della sua carriera politica, il punto di riferimento sia in termini ideali, sia all’interno della DC, e che fino alla fine ha rivendicato di essere stato un moroteo.
Giampiero Guadagni








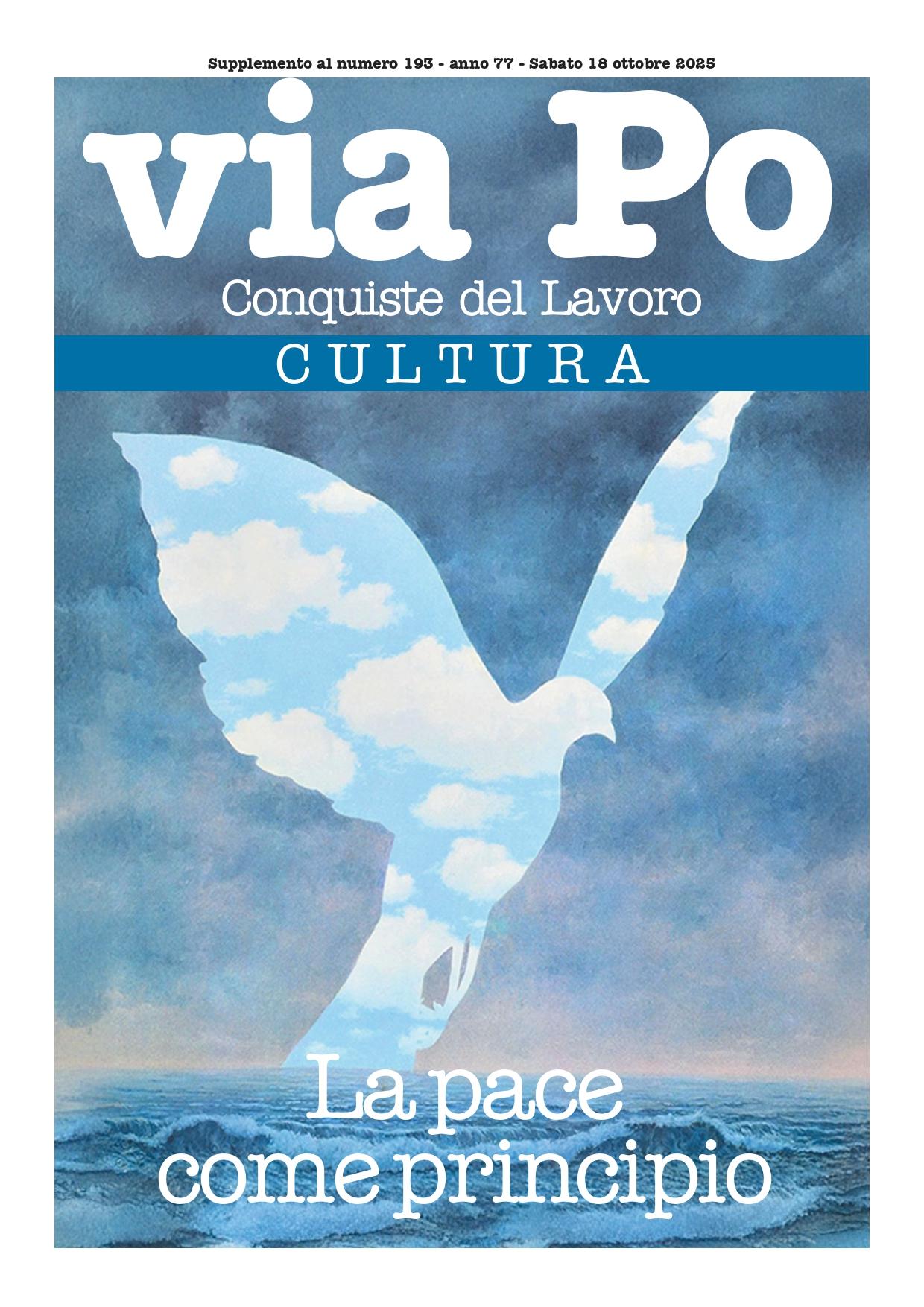.jpg?$p=9d0a4e9)





