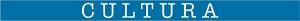Il 2025 si è chiuso lasciandoci una situazione economica generale non dissimile da quella del biennio precedente. L’Italia si trova in una perdurante stagnazione, che rischia di prolungarsi a lungo. Né l’ul tima revisione dell’Istat, che ha aggiornato in aumento il tasso di crescita del Pil nel corso del 2025, portandolo dallo 0,5% allo 0,7% (pari alla metà della crescita dell’eurozona), è in grado di cambiare il tenore della nostra congiuntura economica. Che si presume resti asfittica anche nel prossimo biennio. La Banca d’Italia, infatti, nel Bollettino Economico dello scorso gennaio, prevede per l’anno in corso e per il 2027 una crescita economica pari, rispettivamente, allo 0,6 e allo 0,8%. Confermando dunque che la sindrome dello “zero virgola” continuerà a incombere sull’avanzamento della nostra economia almeno per tutto il biennio prossimo. Non solo. Tali previsioni di crescita comprendono, naturalmente, anche gli effetti delle misure attivate dal PNRR, che scadono proprio nel corso di quest’anno. A significare che, senza quegli effetti, la nostra economia sarebbe certamente in recessione.
I problemi strutturali del sistema Italia
Se il contesto internazionale, così gravido di molteplici tensioni, non garantisce le migliori condizioni per un robusto avanzamento delle principali economie europee, a incidere sui fiacchi risultati dell’economia italiana concorrono cause strutturali ben più consolidate. A cui certamente si sommano quelle congiunturali, legate principalmente alle conseguenze delle tensioni internazionali innescate dal conflitto tra Russia e Ucraina. Di qui, per esempio, il grave problema della bolletta energetica, che per le nostre imprese pesa per il 40% in più di quella delle imprese tedesche e per il 60% in più rispetto alla bolletta energetica delle imprese spagnole. E sul quale, per ora, l’a zione del governo è stata manchevole. Nel frattempo, siamo entrati in quello che il Censis, nel suo ultimo rapporto sulla situazione sociale del Paese, ha definito «un lungo autunno industriale», che solo nel 2025 ha manifestato cenni di contenimento, rispetto ai più forti cali della produzione registrati nei due anni precedenti. Senza, però, che si sia scongiurato il rischio che possa tramutarsi nel «gelido inverno della deindustrializzazione». Tuttavia, le cause principali della nostra stagnazione economica sono consolidate e mostrano radici più profonde. Riguardano, per esempio, il declino demografico, che negli ultimi dieci anni si è tradotto in una flessione della popolazione residente pari a 1,8 milioni di abitanti e ha inciso anche sulla nascita di nuove imprese, non a caso diminuite di seicentomila unità nell’ultimo ventennio. Il fenomeno si è unito all’emigrazione all’estero di tanti giovani in cerca di migliori opportunità, i quali nell’ultimo quindicennio hanno lasciato il Paese nella misura di 630 mila unità. Rappresentando, oltre a un danno per la perdita di capitale umano subita, anche una beffa per il Paese: che ne ha sostenuto, per lo più, i costi della formazione, lasciandosi sfuggire la possibilità di usufruirne delle competenze, nella prospettiva di una più equilibrata e sostenuta crescita economica. D’altra parte, la bassa produttività del lavoro in Italia è legata ad altri noti fattori: una lunga stagione di contenuti investimenti, sia pubblici, sia privati; una percentuale di spesa destinata alla ricerca storicamente più bassa di quella media europea, in quanto, a sua volta, condizionata, oltre che dagli squilibri della finanza pubblica, dall’assetto della piccola dimensione imprenditoriale, che connota, per lo più, il nostro sistema produttivo. Per altro, i bassi investimenti pubblici dell’ultimo trentennio si legano anche alle necessità di gestire la finanza dello stato, zavorrata da un debito enorme. Per il cui servizio l’Italia spende ogni anno più di quanto destina per l’istruzione, o per i servizi ospedalieri, o per gli stessi investimenti pubblici. In questo contesto, quindi, la produttività del lavoro è rimasta praticamente ferma: è cresciuta, tra il 2003 e il 2023, del 2,5%, a fronte di un avanzamento, registrato nello stesso periodo, pari al 16% in Germania e al 18% in Spagna (dati Eurostat). Se quindi la produttività del lavoro langue, le retribuzioni non avanzano. E il Paese, inevitabilmente, arretra.
Quando l’Italia entrò nell’euro, il reddito pro capite italiano era superiore del 15% a quello medio dell’eurozona: oggi, rispetto alla media del reddito dei paesi della zona euro, misura il 20% in meno. Di fronte a questo quadro, la politica economica del governo è risultata quasi impercettibile. Tutta concentrata a perseguire la stabilità della finanza pubblica. Nella prospettiva, riuscita, di migliorare l’affidabilità del nostro debito e quindi il rating delle agenzie internazionali. E nella consapevolezza che la stabilità finanziaria favorisce un abbassamento dei tassi di interesse, che incide sulla diminuzione della spesa per il servizio del debito e può sostenere maggiori investimenti. Quello della stabilità finanziaria, dunque, può essere un importante strumento della politica economica, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo. Non può tuttavia, come ha ricordato Veronica De Romanis su La Stampa del 12 gennaio, essere considerato un fine in sé. Il fine dovrebbe essere la crescita del prodotto interno. Che però, per ora, è risultata assai contenuta.
Lavoro anziano e crescita delle disuguaglianze
Eppure, i dati sull’occupazione sembrerebbero contrastare la stagnazione dell’economia. Con il record raggiunto del numero di occupati e il tasso di disoccupazione più basso di quello medio dell’eurozona. Tuttavia, se si leggono più a fondo, tali dati rilevano un’enorme criticità. Mostrano che il tasso di inattività italiano, pari al 33,5%, è il più elevato d’Europa. Un terzo degli italiani con età compresa tra i 15 e i 64 anni non cerca neanche più un lavoro. E tra gli inattivi, purtroppo, aumentano i più giovani. Insomma, l’occupa zione cresce soltanto a favore degli ultracinquantenni. A causa, sostanzialmente, del rinvio del loro pensionamento dovuto alla legge Fornero. Proprio quella normativa che, ironia della sorte, almeno uno dei partiti di governo in campagna elettorale dichiarava a gran voce di voler superare. Inoltre, come succede in tutti i sistemi economici stagnanti, caratterizzati soprattutto dalla crescita delle rendite finanziarie, anche in Italia nell’ultimo ventennio le disuguaglianze sono aumentate. Come ha ricordato il recente rapporto Oxfam, tra il 2010 e il 2025 il 91% dell’au mento della ricchezza nazionale è finito al 5% più ricco delle famiglie italiane. Anche la disuguaglianza dei redditi è tornata a crescere. In questo senso ha certamente contribuito il generale calo dei salari reali, che dal 2019 al 2024 sono scesi mediamente dell’8%. Ma, a svantaggio dei redditi da lavoro, incide anche un’imposizione progressiva, quella dell’Irpef, mediamente più alta di quella prevista sui redditi da capitale, sui quali nella pratica la progressività non viene applicata. Fenomeno quest’ul timo che ha contribuito, nel corso degli anni, ad esacerbare le suddette disuguaglianze. A tal proposito, la pur apprezzabile riduzione delle aliquote dell’Ir pef, intervenuta negli ultimi anni per gli scaglioni di reddito medio-basso, non potrà di certo contenere le distanze accumulatesi negli anni. Si è tradotta, più banalmente, in un parziale recupero del drenaggio fiscale a cui i lavoratori dipendenti sonno stati sottoposti nell’ultimo quinquennio e che è ammontato a circa 25 miliardi di euro. Insomma, i problemi strutturali dell’economia italiana sembrano essere tali da configurare le condizioni di un vero e proprio declino. La cui direzione appare difficile da invertire. Eppure, la politica economica potrebbe intervenire in modo mirato in alcuni ambiti. Per esempio, in quei settori produttivi in cui si annidano le rendite più alte, favorendo una maggiore concorrenza tra gli operatori. Oppure, nell’ambito del bilancio pubblico, nelle pieghe in cui si concentrano oltre agli sprechi di risorse le distorsioni redistributive più perniciose. «Il problema - come ha recentemente sintetizzato Mauro Magatti ( Corriere della Sera, 7 dicembre 2025) – non è il welfare, ma la sua degenerazione: che si ha quando perde la funzione abilitante e diventa un sostegno passivo in un sistema che non investe sul futuro». Di fronte a una spesa pubblica che è pari a quasi 1.200 miliardi di euro, la sfida dunque non è spendere di più, ma riallocare molte voci di spesa in modo più equo e più efficace. Dalle categorie che hanno saputo tutelare meglio i propri interessi, a quelle che invece sono effettivamente più fragili o si sono maggiormente impoverite. Anche per evitare che in tali gruppi sociali la sindrome dell’apatia e della rassegnazione possa prendere il sopravvento.
Saverio Scarpellino
(Docente di Economia Politica Università Pontificia Salesiana)